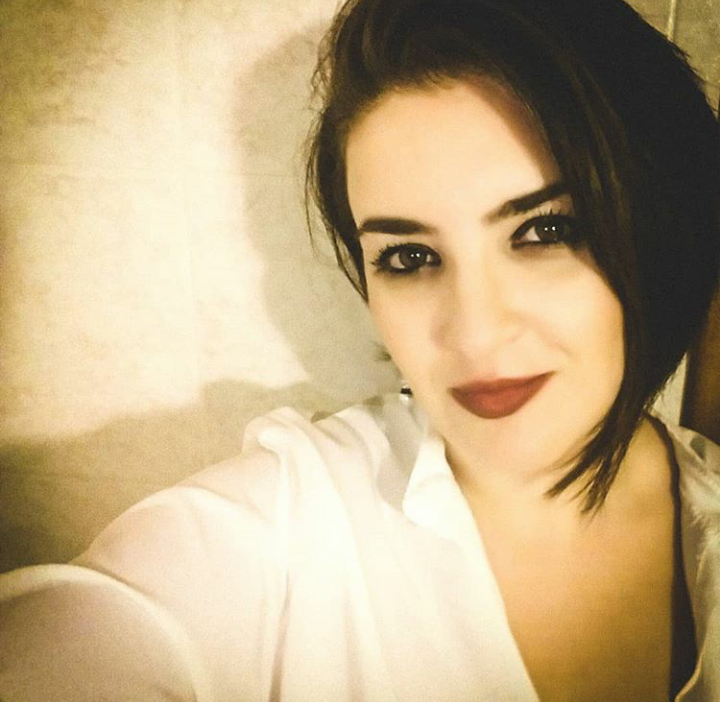Nella distanza della vista, la prossimità dello sguardo: per un’istanza dell’immagine corposa
È un giorno plumbeo d’autunno. Lo percepisco dall’aria libera e fresca che scorre sul mio viso, soffiandomi i capelli in avanti. Si muove innamorata, attratta da sottili steli d’acqua lucenti, che come lame affilate, fendono appena la rugosità delle cortecce delle querce. Qualche foglia trafitta dalla pioggia vien giù, si allontana senza rimorsi dal ramo, ormai sicura d’aver concluso il suo ciclo vitale.
Nell’aria le foglie tracciano liete traiettorie, quasi un commiato ritmico e festoso a quell’albero che le aveva allevate. L’addio è una festa. Una danza libera di aliti di vento, foglie avvinghiate ai gracili fendenti lacrimosi del cielo, e longilinei aghi d’erba, che sprigionando un profumo inebriante e vivace, si preparano ad accoglierle.
È un profumo invadente ma rassicurante che premurosamente accarezza i miei occhi, volontariamente chiusi fuori, ma ben spalancati dentro di me; tanto da rinvenire nelle stanze della mia memoria le immagini di quella campagna stropicciata dalla pioggia e con esse un particolare momento della mia vita; come se la pioggia bagnasse anche la mia anima, nel sortilegio di una clessidra capovolta e torno indietro di un anno. Indietro di un autunno.

A causa di una forte infiammazione agli occhi, lo scorso anno, rifuggivo la luce e con essa la mia macchina fotografica. Per me la possibilità di poter costruire l’inquadratura e consequenzialmente scegliere l’intensità della luce da donare alle immagini, era ed è una delle esperienze più felici. Il timore di non poterlo più fare, mi ha spinta ad un lungo periodo di meditazione, riflessione e ricerca. Volevo guardare negli occhi la mia paura. Addomesticarla e magari farmela amica. Un’amica che potesse guidarmi nel rieducare il mio sguardo, il mio sentire, per cercare di renderli più coinvolgenti e meno prevenuti, ed è cosi che ho scoperto “Il mondo che non vedo”, un affascinante viaggio verso l’altro di Simona Galbiati[1], fotografa e antropologa.
Da antropologa visuale si pone in dialogo col mondo dei non-vedenti per capire se la fotografia oltre a rappresentare l’altro, possa essere un mezzo “per incontrare l’altro, per dialogare con l’altro, per capire l’altro, e superare quella linea di confine che separa dall’altro[2]”, tenuto fuori dalla nostra società bulimica di immagini, famelica di nitidezza, alta risoluzione, like, followers, ma soprattutto di confini ben delineati.
Nei suddetti confini è come se la realtà fuggisse via e perdesse di significato, acquisendo opacità e un carattere ribelle per un ottuso inquadramento ortogonale della perfezione anosmica dei social, determinando consequenzialmente la predilezione per un mondo dai colori intensi ma statici, attraversato da una luce furibonda ma neutra, occupato da soggetti dai movimenti fluidi ma solo in superficie, tradendo, nel sottotesto, una distanza inamovibile dalla possibilità ontica del diverso. E lo sguardo caratteristico di un simile atteggiamento è uno “sguardo inerte di occhio immobile”, questo il significato originario del termine cieco, se si considera la sua origine greca.
Essa sembra alludere, citando la Galbiati, “ad un concetto di cecità che va al di là del piano fisico, riferendosi al pregiudizio, alla ricerca della perfezione, delle linee definite e marcate e dei concetti chiari in cui incasellare ciò che viene considerato normale e accettabile[3]”.
Ma tanto ciò che viene considerato normale, tanto ciò che ad esso si oppone e per questo anormale, diverso, sono costruzioni culturali. Non esistono in natura. L’uomo da sempre per orientarsi nel mondo e per vivere in comunità elabora delle norme, per un anelito di stabilità. Nell’assenza totale di riferimenti da seguire, si cadrebbe facilmente in un’angoscia senza orizzonte e in un immobilismo inerte. Ma attenzione alla sua esasperazione. Essa porterebbe, forse sarebbe meglio dire porta, agli odierni fenomeni d’intolleranza e violenza o peggio ancora, determina la distanza fisica e mentale, nel tempo e nello spazio, dall’altro o meglio dalla possibilità ontica dell’altro.
Una possibilità alla quale la Galbiati non rinuncia. Nella sua analisi sono prese in considerazione i ciechi, non come individui privi di un senso, ma come persone o presenze dotate di una percezione multisensoriale. L’indagine ruota intorno alla percezione e alla memoria, alla loro interazione e all’uso che ne fanno. Solo in questo risiede la nostra distanza dai non-vedenti.
“Siamo così abituati a credere che la percezione passi attraverso la vista che sembra addirittura impossibile pensare che qualcuno possa vivere senza vedere. La vista ha assunto cosi tante forme e sfaccettature che sembra poter sostituire gli altri sensi e, al pari di un oggetto riflesso in una stanza di specchi, sembra aver creato l’illusione di un sensorium completo. Viaggiare dentro la sua realtà (dentro la cecità) regala un altro sguardo: lo sguardo che nasce dalla coscienza e dalla sperimentazione di tutti i sensi, lo sguardo che trascende il visuale e si trasforma in immagini interiori, lo sguardo che sospende i pregiudizi e permette di guardare di sbieco, andando oltre il già conosciuto, facendo spazio all’ignoto[4]”.
Guardare di sbieco, metter da parte i pregiudizi e concepire dentro di sé immagini, questa la sfida quotidiana alla quale anche noi “vedenti” dovremmo sottoporci, in un esercizio costante per cercar di mutar il nostro punto di vista, allenando l’anima alla considerazione della molteplicità e consequenzialmente educare l’udito all’ascolto e il vedere al guardare!!!
In ciò sembra quasi risentire l’eco delle parole del De vita beata di Seneca che recitano così:
“io non bado all’apparenza delle vesti che coprono i corpi, non giudico un uomo con gli occhi, dei quali non mi fido, c’è in me una luce migliore e più sicura con cui distinguo il vero dal falso: è l’anima che deve trovare quel bene che solum è suo.”
Il bene maggiore che potremmo ricavare da questa vita è la consapevolezza di essere qui e ora in dialogo sensibile e perenne non solo con le cose che occupano lo spazio del nostro agire, ma soprattutto con l’altro, riconoscendogli, una volta per tutte, la dignità ontica dell’esserci. Una lezione, questa, impartita a noi “vedenti” dalla percezione aptica, quel tocco coinvolgente di cui è suscettibile il mondo non passibile di emozioni visive e proprio per questo non più distante e rivelato nell’illusione del nostro colpo d’occhio ma vicino, accanto, nella prossimità più prossima dello sguardo intimo del tatto.
Ad esso si aggiunge l’olfatto nella possibilità della seduzione del profumo di stagioni spettinate dal vento, inebriate da odori armonici e suoni rassicuranti provenienti da persone cose ed oggetti che occupano la quotidianità, abitata anche dai ricordi, gestiti dai diversi sistemi mnemonici. Tutto ciò determina non solo la costruzione di una mappa mentale, grazie alla quale orientarsi nel microcosmo nel quale si è inseriti ma soprattutto spinge alla prossimità e alimenta l’immaginazione.
Respirare incanto, meraviglia, sogno, sentire l’urgenza di essere qui ed ora presente in sintonia con l’altro, con gli elementi della natura e con gli oggetti del viver quotidiano e nonostante le costanti amarezze, riuscire a concepire un raffinato senso estetico; come nel caso di non-vedenti intervistati da Sophie Calle nel corso del suo progetto fotografico Blind[5].
Persone nate cieche riescono ad interfacciarsi con la fotografa ed esprimere cosa in essi susciti il sentimento del bello. Molti nel rispondere si abbandonano al ricordo del suono del mare, infuriato, calmo, ma allo stesso tempo rassicurante per quella percezione di vastità; promessa o preludio di una fuga agognata, un sentimento cosi forte da riuscire a descrivere anche le diverse sfumature di quella sconfinata distesa d’acqua, immaginandole certo, ma comunicando forti emozioni.
Altri provano un tal sentimento nel ricordare i capelli lunghi della propria madre, dal profumo avvolgente e dal tatto setoso. Per altri ancora, è il volto di una persona amata. Pur non avendola mai vista, la amano e basta. Senza se e senza ma.
Ce ne sono altre di risposte, disarmanti per la sconfinata semplicità ma dolenti come un pugno sganciato in pieno viso, sui nostri occhi ben aperti fuori ma chiusi dentro!!
Direbbe la Galbiati “se il linguaggio fosse stato creato da un cieco forse esisterebbero molte più parole in grado di descrivere le infinite sfumature dei profumi, di classificare i silenzi e di cogliere le sottili variazioni dei sapori[6]”.
Un’altra testimonianza notevole per la profondità del suo pensiero è di Wolfang Fasser, musicoterapeuta svizzero, diventato cieco a 22 anni. In totale opposizione ai nostri atteggiamenti solipsistici e narcisistici, rifugge lo specchio, preferendo l’incontro e il confronto con l’altro e col mondo. Solo attraverso le suddette pratiche afferma di essere in grado di guardarsi e ritrovarsi:
“Uno specchio non mi serve. Se voglio guardarmi esco. Nel bosco mi vedo. La natura mi attende, mi guarda, mi parla di me. Uno specchio non mi serve se voglio assomigliare a qualcuno penso al faggio. Quando lo abbraccio mi ricopre della sua freschezza, mi riveste della sua semplicità. Uno specchio no. Meglio una passeggiata. Dietro la mia casa ogni mattina incontro una pianta di rosmarino. La strofino tra le mani per liberare il suo odore chiaro, netto, purissimo. Sento, odoro, ascolto. Così imparo chi sono e perché sono qui[7]”.
Sono testimonianze importanti atte a suggerire “la consapevolezza di un’estetica sensibile, che va al di là della vista e che coinvolge tutti i sensi, avvicinandosi al suo significato originale. Estetica, dal greco aistetikos, infatti significa sensibile, capace di sentire, percepibile attraverso i sensi, come spiega Paquita: il senso estetico è la morbidezza, la dolcezza, l’armonia, il tatto piacevole che trasmette calore e soavità; un profumo, un suono, una carezza, stare (essere presente), un ambiente come un bosco ossia tutto quello che puoi percepire con i quattro sensi che non siano la vista[8]”.
Un” tatto piacevole” rappresenta il primo stadio fondamentale del complesso processo di presentificazione del sé e dell’altro da sé e del mondo dentro del sé, suscettibili di infinite traduzioni in immagini corpose, nel senso che è possibile vedere con l’interezza del corpo, imprimendo alle immagini cosi elaborate una porzione della propria essenza.
Esemplificativi a tal proposito diventano le testimonianze di diversi fotografi ciechi.
Primo fra tutti Gerardo Nigenda umile servitore di sensi ed emozioni di cui nutre le sue immagini e l’istante che lo spinge a scegliere una determinata porzione di realtà. “Devi relazionarti intimamente con l’immagine. Devi toccare, annusare, leccare se necessario[9]”.
“Per lui fotografare è vivere un’esperienza sensuale in cui coinvolgere tutti i sensi[10]” per comunicare, per rivendicare la sua presenza nella società malata di oculocentrismo, servendosi non solo d’ immagini ma anche di parole. Attraverso una descrizione o una poesia può fare in modo che lo spettatore si accosti al suo mondo e ne percepisca le intenzioni, i motivi che lo hanno portato a ritagliare quel frammento di vita.

Sono davvero tante le esperienze e testimonianze di ciechi che sono riusciti a fare della fotografia un lavoro. Tra esse la storia che più mi ha emozionata porta il nome di Evgen Bavcar.
Filosofo e fotografo cieco dallo sguardo onirico, sloveno di nascita ma abitante del mondo. Erede di Eros, proprio come il dio abitante delle tenebre. Si autodefinisce tale non solo per la sua condizione fisica ma anche e soprattutto per la prossimità con l’oggetto della sua percezione: “se tocco sono in una percezione erotica, senza la distanza dell’occhio[11]” un gesto estremamente delicato e profondo, tale da descrivere così una donna che ha amato:
“ho toccato i suoi capelli e ho pensato: è come un'arpa sostenuta dal vento. Ho accarezzato il suo volto: un orologio, rotondo, preciso, perfetto. Ho sfiorato la sua bocca, una ciliegia nel mese di maggio. E il suo corpo: un Sapiente di fronte al teorema di Pitagora”.

Eppure come è possibile intuire dalle suddette citazioni, dal buio partorisce la luce, la luce abbacinante delle sue immagini corpose, mistici sudari in cui è vibrante il desiderio ottico dell’immaginazione, quel passo audace, per mezzo del quale il fotografo travalica i confini del visibile e costruisce una nuova utopia: la tangibilità dell’invisibile, affrancandosi dalla schiavitù della società oculocentrica riuscendo a mantenere desta la sua fantasia creando un’immagine[12].
È come se la sua mente fosse una camera oscura, li elabora le sue figure, unendole in spirituali nozze con traiettorie di riverberi di una luce lontana nello spazio ma ben viva nei suoi ricordi. Imprime un movimento, un’espressione, costruisce intorno uno spazio, che dialoga col soggetto dell’inquadratura, tutto attraversato dal perfetto equilibrio tra percezione, memoria, sogno e immaginazione.

Un’ immaginazione che lui ha sempre alimentato, soprattutto nel periodo del lungo addio alla luce. Prima che diventasse totalmente cieco sono trascorsi sei mesi, durante i quali ha registrato ogni virgola del mondo che lo circondasse, ogni intensità di luce, ogni espressione, ogni movimento, ogni battito di tutto ciò che fosse visuale. È da questi appunti che trova materiale fecondo per elaborare le sue immagini, che restano li nella galleria interna della sua mente.
Quando i destinatari dei suoi preludi emozionali sono persone, avvicina la macchina fotografica all’altezza delle loro labbra ascoltandone poi la voce, utilizzando a volte un esposimetro vocale per misurare la luce e all’occorrenza anche un apparato vocale per identificare i colori.
Nutrici accorte per la messa in opera delle sue immagini nel mondo, sono persone che, come la nipote Veronica, scevri da sovrastrutture e fantasmi, descrivono le foto realizzate. La descrizione è il suo unico accesso fisico al visibile, , a patto di riuscire ad educare lo sguardo dell’interlocutore, in modo che il suo occhio fisico cerchi solo l’essenziale, e il fotografo sia sicuro di scegliere quella foto e non un’altra.
Non chiedetevi come faccia a fotografare ma perché lo faccia!! La fotografia è un atto politico una lotta per il diritto di parola dei non-vedenti, diritto di percepire e immaginare, l’ausilio magico per poter esercitare un controsguardo.
In un mondo dove è reale solo ciò che è visibile, ingombro di “razzismo visuale[13]”, segnato dal rifiuto di persone che possono percepire il mondo in un’altra maniera, per Bavcar la fotografia diventa la prova tattile da mostrare ai vedenti della sua esistenza, del suo esser qui ed ora, sottolineando la totale iniquità tra gli sguardi. Un cieco può esser visto ma non può guardare, manca un controsguardo e con la fotografia ciò diventa possibile.
La fotografia corposa dei non vedenti come luogo, dove far impattare, intersecare e moltiplicare le visioni del mondo, visibile e invisibile, ci insegna a metter da parte le nostre esasperanti ossessioni, i nostri fantasmi ; nella possibilità dell’incontro autentico non soltanto con noi stessi e con quel che di migliore potremmo essere ma soprattutto con l’altro da noi e con tutto ciò che è radicalmente altro da noi nel tentativo di avviare un confronto produttivo atto a cambiare la rotta egoriferita della distruzione di ogni umano sentire, a ridefinire i confini dei nostri principi d’intelligibilità del mondo, a storicizzarli guardandoci nel fondo della nostra medesima umanità in una scandalosa prossimità dialogante.
Del resto come direbbe Bavcar: “Meglio sentire la vita che avere soltanto un’idea della vita” e aggiunge “Quanti veramente ‘vedono’?[14]”.

Note
[1] Simona Galbiati ha lavorato dieci anni con le nazioni unite a Trinidad e Tobago, in Egitto e in Italia, occupandosi di violenza di genere e infanzia. Laureata in economia presso l’Università Bocconi di Milano, ha successivamente intrapreso i suoi studi in Antropologia, dedicandosi all’antropologia visuale e all’antropologia dei sensi, presso l’Universitat Autonoma di Barcelona.
[2] Cit. Galbiati, Il mondo che non vedo, Bonanno Editore, Reggio Calabria 2014, p. 25.
[3] Ivi, p. 36.
[4] Ivi, pp. 90-91.
[5] L’artista riflette sull’assenza di un senso e sulla sua compensazione e sui concetti di visibile e invisibile. Il libro raccoglie tre lavori fotografici dedicati al tema della cecità, elaborati in diversi momenti professionali della Calle. Nel primo lavoro Blind (1986) chiede ai non-vedenti di parlarle della loro idea di bellezza, in Blind Color(1991) si sofferma sulle percezioni dei suoi intervistati, confrontandole con descrizioni di artisti; mentre nell’ultimo progetto che porta il nome "The last image", realizzato a Istanbul, raccoglie gli ultimi ricordi visivi di persone che hanno perso la vista.
[6] Cit. Galbiati, p 121.
[7] Ivi, p 116.
[8] Ivi, p 117.
[9] Ivi, p. 154.
[10] Ibid.
[11] Cfr. www.raiplayradio.it, audio 2017/12, Nostalgia della luce di Evgen Bavcar.
[12] Cfr. Galbiati. Il mondo che non vedo, p 158.
Bibliografia
- Calle, Sophie, 2011, Blind, Actes Sud.
- Galbiati, Simona, 2014, Il mondo che non vedo, Bonanno Editore, Reggio Calabria.
Sitografia
- https://www.youtube.com/watch?v=bQMzcWcw5tQ (Evgen Bavcar per l’arte plurale)
- https://www.raiplayradio.it/audio/2017/12/Nostalgia-della-luce-di-Evgen-Bavcar-ac6c5ee6-a221-4f8b-b402-2f1ba374d14a.html